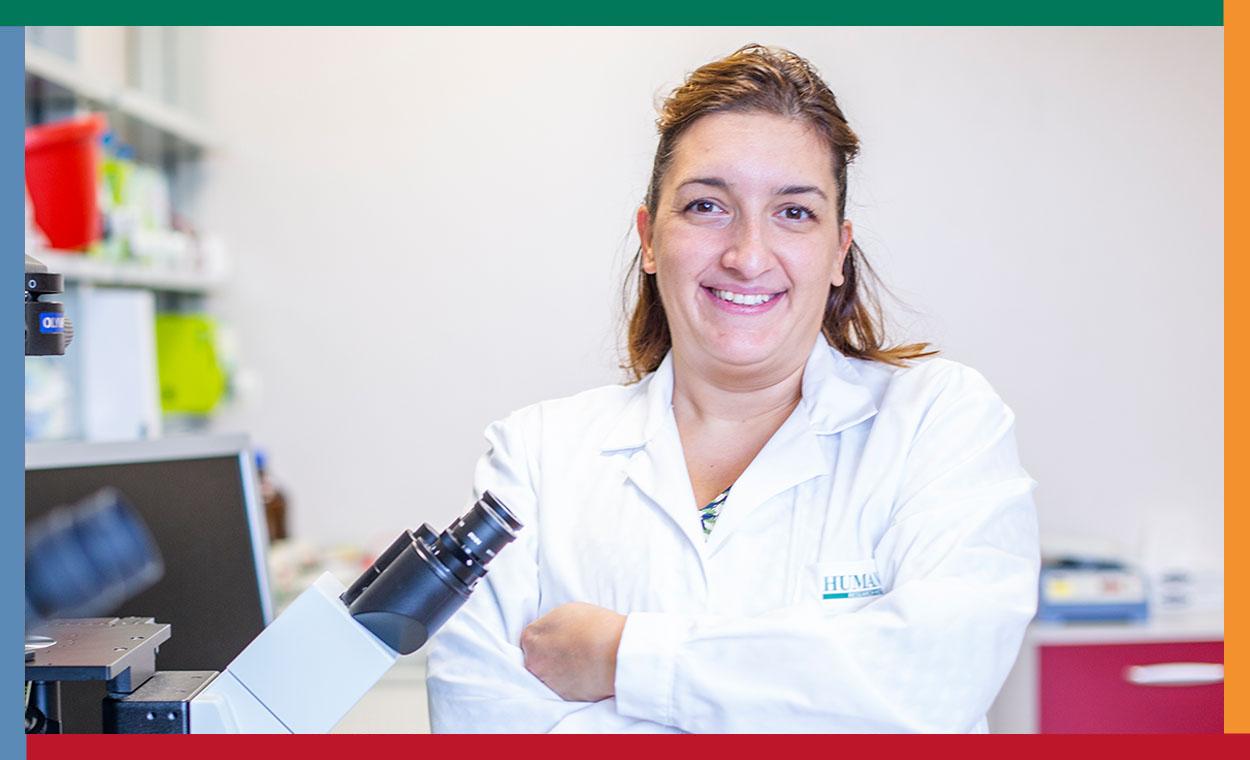Ritratto di scienza, parliamo di cervello e Ricerca all’estero con Simona Lodato
Simona Lodato è Group Leader presso Humanitas Research Hospital, dove dirige il Laboratorio di Biologia dello Sviluppo Neurologico. Dal 2018 Simona è membro della Fens-Kavli Network of Excellence (FKNE), una rete di neuroscienziati che forniscono consulenza sulle strategie di ricerca per plasmare il futuro delle neuroscienze in Europa. Ha conseguito il dottorato nel 2011 presso la European School of Molecular Medicine (SEMM) e l’Università “Federico II”, a Napoli, sotto la supervisione della Dr.ssa Michèle Studer. Ha svolto il suo lavoro di Ricerca inizialmente presso il Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM) e poi a Boston, come studente in visita presso il Massachusetts General Hospital, concentrandosi sulle malattie rare legate a uno degli organi più misteriosi del corpo umano: il cervello.
Il laboratorio di Biologia dello Sviluppo Neurologico ha l’obiettivo di decodificare il dialogo tra fattori genetici e ambientali che governano lo sviluppo di microcircuiti nella corteccia cerebrale. Questi circuiti hanno un ruolo fondamentale nell’esecuzione di comportamenti complessi e la loro disfunzione è coinvolta in molti disturbi neuropsichiatrici e dello sviluppo neurologico.
Simona, cosa hai studiato durante gli anni del dottorato?
Mi sono occupata di studiare i meccanismi molecolari che controllano la generazione di gruppi distinti di interneuroni inibitori nella corteccia cerebrale dei mammiferi in via di sviluppo. Un tema complesso da capire per i non addetti al lavoro: per semplificare possiamo dire che gli interneuroni sono neuroni di collegamento e che svolgono una funzione fondamentale nella formazione dell’elaborazione sensoriale e nella plasticità del cervello, sia quando è maturo sia quando è ancora in fase di sviluppo.
Gli interneuroni sono suddivisibili in classi che hanno proprietà diverse: sappiamo che il loro funzionamento non corretto determina vari disturbi neurologici, ma c’è ancora tanto da scoprire sul ruolo esatto dei vari sottotipi di interneuroni, nelle diverse malattie e anche quando il cervello “è sano” e funziona correttamente. Le neuroscienze, e in particolare il tema del neurosviluppo, mi hanno sempre interessato molto.
Quanto è stata importante l’esperienza all’estero?
Quando ho vinto la borsa di dottorato alla SEMM, sono stata molto felice per tante ragioni: perché si trattava del primo dottorato italiano interamente svolto in inglese e perché ero tra le prime biologhe a intraprendere questo percorso e a poter beneficiare di questa importante possibilità.
Il percorso prevedeva quattro anni al posto dei classici tre e mi sembrava la scelta migliore per mettermi in gioco. Di fatto sono stata a Napoli solo per un breve periodo del mio percorso di dottorato, nel laboratorio del Telethon Institute. Poi sono partita per gli Stati Uniti. Gran parte dei successivi anni del mio training li ho trascorsi a Boston, presso il Massachusetts General Hospital. Questa esperienza nel più grande ospedale della costa orientale mi è stata molto utile, anni dopo, per impostare anche il mio lavoro qui in Humanitas.
A Boston ho approfondito soprattutto le tematiche di ricerca legate agli aspetti molecolari alla base del neurosviluppo e ho scoperto una città fortemente dinamica e un ambiente lavorativo molto motivante per un ricercatore. Avevo la netta sensazione di star imparando tanto e questa crescita professionale era davvero entusiasmante. Intanto, anche la mia vita personale al di fuori del lab cresceva: ho concluso il mio percorso di dottorato quando ero incinta di cinque mesi, discutendo la mia tesi col pancione.
L’esperienza di dottorato all’estero è stata così appagante che ho scelto di restare negli USA. Ho fatto un post-doc alla Harvard University, dove mi sono occupata ancora di formazione dei circuiti neuronali del sistema nervoso, concentrandomi su alcune tecnologie all’avanguardia come l’analisi dei neuroni a singola cellula, per ottenere informazioni più approfondite sull’architettura complessa del cervello.
Sappiamo davvero così poco del cervello?
Negli ultimi anni ci sono state tre grandi rivoluzioni che hanno permesso a noi scienziati di fare importanti passi in avanti e che sono al centro del mio lavoro in Humanitas.
Primo il boom delle scienze omiche (genomica, proteomica, trascrittomica ecc.): discipline che permettono di produrre grandi quantità di dati in un intervallo di tempo, fondamentali per studiare in modo mirato un sistema biologico o i circuiti neurali. Applicare le scienze omiche al cervello è rivoluzionario perché ci consente di studiare, anche dal punto di vista evolutivo, qualcosa che è sempre stata una “scatola chiusa”.
La seconda rivoluzione è rappresentata dalla possibilità di lavorare con le cellule staminali indotte. Nascendo da cellule somatiche che possono essere cellule del sangue, della pelle, della mucosa della bocca, sono facili da prelevare e non hanno implicazioni etiche. Le staminali indotte vengono condizionate in un secondo momento per “regredire” e tornare a essere cellule pluripotenti, in grado di diventare qualsiasi cellula del nostro corpo. Le possiamo personalizzare e conosciamo nei minimi dettagli la loro storia genetica. Possiamo usarle per seguire il differenziamento delle cellule in tessuti e la loro evoluzione, per studiare il neurosviluppo o la neurodegenerazione.
La terza rivoluzione è quella degli organoidi: riusciamo a fare in modo che i tessuti in vitro si organizzino a livello tridimensionale per mimare la struttura dell’organo. Per il cervello c’è ancora molta strada da fare ma in collaborazione con il Prof. Roberto Rusconi e il Dr. Paolo Oliva, e con alcuni colleghi del Politecnico di Milano, stiamo lavorando con la tecnica del bioprinting, per fare in modo che le cellule prodotte spontaneamente dall’organoide “cervello” assumano la struttura “corretta”, più simile a quella funzionale.
Tutto questo cosa significa in ottica di cura?
La comunità scientifica si sta avvicinando, anche per il cervello, allo sviluppo di una medicina di precisione. Tra i campi più promettenti c’è quello della medicina rigenerativa: grazie alle staminali si possono potenzialmente rigenerare i tessuti del corpo, neuroni compresi. Una delle condizioni neuropatologiche che oggi sta beneficiando maggiormente di queste innovazioni è il Parkinson. Ad oggi sono attivi sette trial clinici che prevedono l’impianto di neuroni dopaminergici (quelli che muoiono nel Parkinson) nei pazienti. E i risultati sembrano molto promettenti.
Queste importanti sperimentazioni hanno un collegamento significativo con la mia ricerca. Le cellule staminali ed embrionali e le cellule staminali pluripotenti indotte sono anche alla base del nostro lavoro di costruzione degli organoidi di pazienti con malattie neurodegenerative o del neurosviluppo. La frontiera della cell therapy è in espansione e questa è un’ottima notizia.
Come nasce la passione per le neuroscienze?
Ho sempre pensato di voler studiare medicina. Mio padre è medico e mia madre insegnante e da bambina ero convinta che da grande avrei fatto la pediatra. Il test di medicina però è stata per me un’esperienza spiacevole. Non sono passata per pochi punti e mi sono iscritta alla facoltà di Biologia per ritentare l’anno successivo.
Fin dai primi mesi di studio, però, ho capito una cosa per me fondamentale. Studiare medicina per curare il paziente, senza avere un background di tipo molecolare, senza avere, cioè, la possibilità di comprendere in modo dettagliato i meccanismi alla base delle malattie, sarebbe stato per me frustrante. Quindi quel piccolo “fallimento” al test di medicina è stata la mia salvezza: ho trovato la mia strada. Il cervello è la frontiera più lontana per un biologo molecolare, perché c’è ancora tantissimo da scoprire e forse è questo che ha acceso in me la passione per le neuroscienze.
Amo moltissimo il mio lavoro tanto che spesso fatico a trovare il giusto equilibrio tra ricerca e tempo da dedicare alla vita al di fuori del laboratorio. Mi ritengo fortunata: anche nei periodi più difficili, ho il privilegio di fare un lavoro che mi piace e che ancora mi entusiasma molto. Penso spesso che, se per qualche motivo non dovessi più fare ciò che faccio, cambierei completamente… Forse aprirei una libreria in un posto caldo, magari in Grecia o in Spagna.
Perché hai deciso di tornare in Italia?
Quando ho finito il mio percorso ad Harvard ho cominciato a guardarmi intorno: sapevo che volevo fare Ricerca in modo indipendente ed era arrivato il momento di mettere radici, almeno per qualche tempo. Il post-doc è durato 6 anni e nel frattempo era nato il mio secondo figlio. Alla fine del 2016 ho iniziato a tastare il terreno: volevo occuparmi di Ricerca di base ma con un orientamento concreto. Ero affascinata dalla Ricerca traslazionale e credevo potesse fare al caso mio.
Ho avuto diverse offerte, dalla Columbia University, dall’Università di Losanna e altre ancora. Non mi sono mai considerata un cervello in fuga. Anche ai miei studenti ripeto sempre che devono partire, sperimentare, cogliere le occasioni. La Ricerca dovrebbe diventare sempre di più un mondo senza confini, promuovendo lo scambio e un via vai proficuo di menti. Non ci sono cervelli che fuggono o che ritornano per come la vedo io, ci sono Paesi che investono in Ricerca e sviluppo tanto da diventare attrattivi.
L’Italia non è ancora un Paese competitivo per fare Ricerca. Ma ci sono delle eccezioni meritevoli. Nel 2018 stavo per firmare con l’Università di Losanna quando sono stata contattata dalla Professoressa Michela Matteoli, che all’epoca non conoscevo e che mi ha raccontato di un bellissimo progetto, molto ambizioso: voleva costruire un NeuroCenter e l’idea mi ha conquistato, così come la possibilità di insegnare alle nuove generazioni di medici.
Oggi siamo un piccolo dipartimento di Ricerca sul cervello, molto affiatato. Tutti motivati e con competenze altamente specializzate, in grado di attrarre finanziamenti competitivi che sostengono i nostri programmi sperimentali, che portiamo avanti insieme a giovani ragazzi e ragazze volenterosi. Le nostre conoscenze e competenze sono diverse tra loro e ciò ci dà ancora più forza. La strada è ancora lunga ma l’entusiasmo non manca!